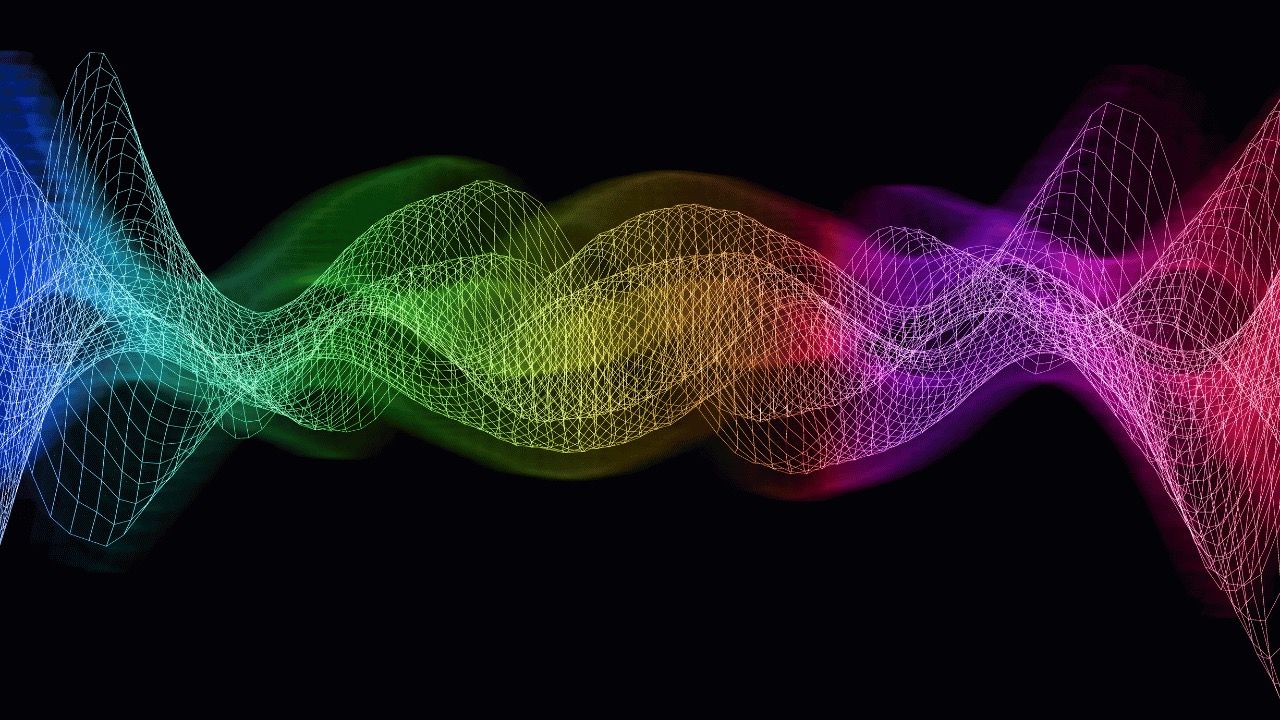La Befana, simbolo universale
I buddhisti tibetani, il cui cielo mentale è abitato dalle Dakini, sono abituati all’idea di una figura femminile in volo. Se poi vivono in Italia, sin da piccoli sono stati affascinati dalla figura della Befana, una delle più antiche e coinvolgenti tradizioni del nostro folklore.
L’anziana donna, che volando su una scopa appare ogni anno, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, per portare doni ai bambini buoni e carbone ai più dispettosi, spesso descritta come una strega gentile, incarna in realtà l’intersezione di riti millenari, tradizioni cristiane e credenze popolari, configurandosi come un simbolo culturale ricco di significati.
Dal punto di vista antropologico, l’idea della Befana affonda le radici in rituali precristiani legati ai cicli agricoli e cosmici. Nell’antichità, durante i dodici giorni dopo il solstizio d’inverno, avevano luogo festività, come i Saturnali romani o le feste in onore della dea Diana, che celebravano il periodo di transizione e rigenerazione e l’avvento di un nuovo anno agricolo, e che hanno lasciato nella memoria collettiva un solco profondo. La Befana in questo contesto incarna al contempo la fine e la promessa di rinnovamento. Vecchia e a cavallo di una scopa, è una Madre Natura consumata, che si sacrifica per consentire la rinascita primaverile. La scopa stessa, oggetto associato alla pulizia, assume una funzione rituale di purificazione. Nonostante ci possa intimorire, dunque, la vecchia non è affatto maligna, ma custode di un’antica saggezza legata alla terra e ai cicli delle stagioni.
La tradizione si intreccia poi strettamente con figure archetipiche e spirituali del femminile, prime quelle della maga e della sciamana. Nella tradizione “pagana” e nei miti popolari, le streghe e le sciamane erano considerate donne con conoscenze profonde del mondo naturale e delle forze spirituali. Erano guaritrici, interpreti dei segni e mediatrici tra il visibile e l’invisibile, depositarie della qualità intuitiva e della saggezza antica e certamente legate al potere rigenerativo della natura. La Befana ne incarna una versione domestica e rassicurante. A differenza delle streghe malefiche, la sua scopa, simbolo di purezza, è usata non per incantesimi oscuri, ma per spazzare via l’anno vecchio e fare largo al nuovo.
Il 6 di gennaio può quindi essere visto come una celebrazione del femminile, in cui aspetti come la trasformazione, la cura e la saggezza vengono simbolicamente ricordati e onorati.
Con l’avvento del Cristianesimo, molte tradizioni furono assimilate e reinterpretate. La Befana fu associata alla festività dell’Epifania, che ricorda la rivelazione di Gesù ai Re Magi. La leggenda racconta che i Magi, durante il loro viaggio verso Betlemme, chiesero indicazioni a una vecchia donna. Quest’ultima, inizialmente reticente, si pentì e cercò di raggiungerli, recando con sé doni per il neonato Messia. Non riuscendo a trovarlo, distribuì i suoi regali ai bambini che incontrava lungo il cammino. Un tipico esempio di sincretismo culturale, in cui l’icona della Befana, con i suoi tratti precristiani, è reinterpretata per adattarsi ai nuovi valori, in particolare la generosità e la redenzione.
La Befana, nella sua duplice natura di strega e benefattrice, incarnazione della speranza, del cambiamento e della generosità, rappresenta in realtà una figura universale, in grado di volare attraverso i confini delle culture e delle religioni. La sua celebrazione ci ricorda l’importanza delle radici e della magia che si cela nei gesti quotidiani.
Di certo, con il suo sacco di doni e la sua scopa, continuerà a lungo a volare nei cuori degli italiani, portando con sé l’antica saggezza e le promesse del futuro.